“Un giorno questo dolore ti sarà utile” di Peter Cameron
Saggistica breve, Letteratura, Adelphi, Un giorno questo dolore ti sarà utile, Peter Cameron
La corsa risibile del mondo. “Un giorno questo dolore ti sarà utile” di Cameron, ed. Adelphi
@ Agata Motta, 1 novembre 2023

Un titolo assolutamente perfetto e irresistibile che attinge alla saggezza latina per consegnarla alla frenesia del presente. Con un titolo diverso, Un giorno questo dolore ti sarà utile, il romanzo di Peter Cameron edito da Adelphi, forse non avrebbe volato così alto e non avrebbe goduto di una presenza così pervasiva. Non si tratta di una lettura deludente, il dolore gelido eppur sanguinante che ne percorre le pagine, non è di quelli che può indurre indifferenza, ma probabilmente è proprio da quella frase che scaturisce il fascino che accompagna il lettore alla ricerca di indizi che possano condurre a trovare l’utilità promessa. Ed è ovvio restare intrappolati in quelle parole, perché a tutti capita prima o poi di incappare in un dolore insopportabile, di dover sorreggere macigni su spalle troppo deboli, di affrontare agonie corrosive, di avvertire i morsi della disperazione e nessuno si sottrae all’illusione di poter individuare alla fine la funzione e il senso di tanta sofferenza.
Cameron naturalmente non la indica questa benedetta utilità, la lascia intravedere in un futuro che il giovanissimo James non racconterà, conficcato in un difficile percorso di crescita interiore nel quale il domani rappresenta una grossa incognita da decifrare giorno dopo giorno. Qualcosa nell’insofferenza per le ipocrisie e le convenzioni sociali riporta alle atmosfere de Il giovane Holden, ma se quello di Salinger è romanzo di formazione, in Cameron il processo appare bloccato e non sembra che le esperienze vissute, talvolta provocatorie e trasgressive, producano vistose risonanze nell’interiorità di un personaggio sotto certi aspetti insondabile, specie quando aspetta passivamente che si manifestino gli effetti del suo agire o del suo ipnotico torpore.
La narrazione in prima persona, che concede ampio spazio a dialoghi efficaci, consente un’adesione immediata allo sguardo triste del protagonista. Adottare il suo punto di vista significa guardare il mondo da un’altra angolazione, quella di chi non si adatta alle dinamiche relazionali ritenute “normali”.
Quella di James è una famiglia complicata come tante altre, genitori separati, una sorella lontana e assorbita dai suoi piccoli problemi che ogni tanto concede barlumi di complicità, una nonna saggia e originale che è l’unica capace di ascoltarlo e soprattutto di accettarlo senza pretendere di cambiarlo. La madre passa da un matrimonio all’altro ‒ l’ultimo si concluderà durante il viaggio di nozze ‒ alla continua ricerca di un amore che possa colmare il suo vuoto, il padre osserva un po’ discosto questo figlio nel quale intravede con timore la diversità. A modo loro entrambi pensano di amarlo e non riuscendo a sintonizzarsi con il suo universo lo spingono a sedute di psicanalisi sterili ed inconcludenti.

Peter Cameron
James lavoricchia nella galleria d’arte della madre (ma cerca ossessivamente su Internet case nelle quali far dimorare la sua inquietudine) in attesa di accedere a studi universitari che non vuole intraprendere, ma verso i quali tutti lo spingono a forza come se quella di proseguire gli studi fosse una scelta ineluttabile. La rappresentazione del piccolo spaccato della galleria, quasi sempre deserta, è caustica e a tratti esilarante. L’ultima esposizione è quella di un artista giapponese che propone bidoni della spazzatura a 16.000 dollari l’uno e James sembra l’unico a mostrare qualche perplessità sulla presunta genialità dell’operazione, proprio lui che dall’angolino seminascosto del suo “disadattamento” elabora un pensiero razionale sulle mistificazioni presenti nel mondo dell’arte. Lì stringe amicizia con John, l’altro impiegato, ma anche questa sarà un’esperienza fallimentare e dolorosa, perché priva di una presa di coscienza reale del particolare approccio con il mondo esterno cui il ragazzo è costretto dai tortuosi percorsi della sua mente. Uno scherzo finito male, o forse sarebbe più corretto dire un vero e proprio tentativo di adescamento online, produce una serie di reazioni a catena che portano James al riconoscimento della propria omosessualità, dettaglio in fondo per lui insignificante.
Pian piano tutto si ricompone lasciando addosso al lettore un senso claustrofobico di prigionia. Si intuisce che James continuerà a vagare in un labirinto senza alcuna volontà di trovare vie d’uscita e che il disagio continuerà a camminargli a fianco. Più che alle persone, James attribuirà agli oggetti, quelli appartenuti alla nonna, il compito di una utilità futura, muti residui di ore serene, muti testimoni non giudicanti che sanno aspettare. Il mondo fuori invece continuerà la sua corsa, lasciando ai margini chi non riesce a mantenere il ritmo e chi procede con andatura anomala. Tanti, troppi. Arriveranno ugualmente sperimentando altre soluzioni, ma forse il loro dolore non sarà stato utile come sperato.
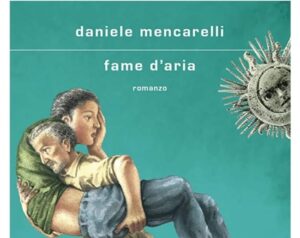



 Non sorprende trovare Rubare la notte di Romana Petri, Mondadori editore, nella cinquina dei finalisti del Premio Strega, quello che stupisce semmai è che una talentuosa, raffinata, poliedrica scrittrice e traduttrice come lei non lo abbia già ottenuto in precedenza e che romanzi straordinari come Ovunque io sia, Le serenate del Ciclone e Figlio del lupo siano stati lasciati semplicemente al loro successo.
Non sorprende trovare Rubare la notte di Romana Petri, Mondadori editore, nella cinquina dei finalisti del Premio Strega, quello che stupisce semmai è che una talentuosa, raffinata, poliedrica scrittrice e traduttrice come lei non lo abbia già ottenuto in precedenza e che romanzi straordinari come Ovunque io sia, Le serenate del Ciclone e Figlio del lupo siano stati lasciati semplicemente al loro successo.
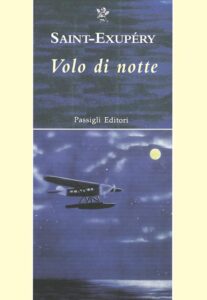 In filigrana compaiono le guerre – per una beffa anagrafica (Saint-Exupéry nacque nel 1900) mai pienamente combattute ad esclusione di quella civile spagnola – che lo infiammano di amor patrio. E per amore dell’amatissima Francia l’ormai osannato scrittore andrà negli Stati Uniti a caldeggiare un intervento americano, ma la manifesta ostilità per De Gaulle gli varrà l’accusa, sempre respinta con amarezza, di collaborazionismo.
In filigrana compaiono le guerre – per una beffa anagrafica (Saint-Exupéry nacque nel 1900) mai pienamente combattute ad esclusione di quella civile spagnola – che lo infiammano di amor patrio. E per amore dell’amatissima Francia l’ormai osannato scrittore andrà negli Stati Uniti a caldeggiare un intervento americano, ma la manifesta ostilità per De Gaulle gli varrà l’accusa, sempre respinta con amarezza, di collaborazionismo.



 Giunto all’ingrato approdo dei sessant’anni con la consapevolezza della propria rassegnazione ad un opaco presente di depressione e di contratture fisiche ed emotive, l’accordatore di pianoforte Orlando – lo stesso Papaleo che firma anche sceneggiatura (con Valter Lupo) e regia – avverte con sempre maggiore insistenza la voce critica (e la presenza fisica) del se stesso giovane (il solare Simone Corbisiero), allegro e pieno di speranze, e di un passato, chiuso ormai fuori a doppia mandata, che vorrebbe confusamente risucchiarlo. Il motivo si scoprirà poco alla volta, perché in quel passato è da collocare il trauma che ha portato il giovane Orlando alla fuga da Lauria, il paese lucano di origine, nonostante il forte legame che lo univa alla bellissima madre (Manola Rotunno), della quale malvolentieri aveva accettato le seconde nozze con l’albergatore Rocchino (Jerry Potenza) e all’esuberante sorella Rosanna (valida e calzante Angela Curri). La possibilità di riavvolgere il nastro e di sciogliere l’amaro garbuglio che ne ha fatto un eterno irrisolto, gli viene offerta da una giovane fisioterapista – Giorgia in un dignitoso debutto come attrice che non nega comunque la sua straordinaria voce – che, avvertitane la desolata fragilità, lo esorta a tornare in Basilicata per recuperare una foto di gioventù attraverso cui operare un confronto con la contratta postura attuale. La sua bella terra, mostrata in inquadrature di struggente bellezza e ammantata di nostalgia, è amata di incondizionato amore anche quando si rivela impermeabile tanto al male quanto al bene e risultano pertanto corrosive, polemiche ed esilaranti alcune scene, come quella in cui nessuno mostra entusiasmo per la nomina di Matera a Capitale europea della cultura 2019 e quella in cui il becero automobilista che gli offre un passaggio prospetta per Potenza uno sviluppo futuristico in stile Dubai. Lì, a Lauria, si trova il bandolo della matassa e della semplice storia del mite Orlando, avvezzo ad un consumo ormai anestetico di spinelli e disposto ad arrabbiarsi solo su discutibili e anacronistiche questioni di principio, si recupera il passato in ampi flashback. La politica, gli intrallazzi e il terrorismo hanno teso una corda sul suo cammino. Lui non è inciampato, ma lo hanno fatto le persone più care, soprattutto la sorella che non si innamora di un’ideologia, quanto della sua distorsione e del suo malinteso senso di giustizia radicale. E allora la fuga si prospetta come il male minore, la soluzione più comoda, la pietra tombale sulla gioia e sulla poesia che aveva coltivato sin da bambino, persino sul dialetto cui lo sprona invece il giovane se stesso suggerendo così che senza le radici si appassisce soltanto.
Giunto all’ingrato approdo dei sessant’anni con la consapevolezza della propria rassegnazione ad un opaco presente di depressione e di contratture fisiche ed emotive, l’accordatore di pianoforte Orlando – lo stesso Papaleo che firma anche sceneggiatura (con Valter Lupo) e regia – avverte con sempre maggiore insistenza la voce critica (e la presenza fisica) del se stesso giovane (il solare Simone Corbisiero), allegro e pieno di speranze, e di un passato, chiuso ormai fuori a doppia mandata, che vorrebbe confusamente risucchiarlo. Il motivo si scoprirà poco alla volta, perché in quel passato è da collocare il trauma che ha portato il giovane Orlando alla fuga da Lauria, il paese lucano di origine, nonostante il forte legame che lo univa alla bellissima madre (Manola Rotunno), della quale malvolentieri aveva accettato le seconde nozze con l’albergatore Rocchino (Jerry Potenza) e all’esuberante sorella Rosanna (valida e calzante Angela Curri). La possibilità di riavvolgere il nastro e di sciogliere l’amaro garbuglio che ne ha fatto un eterno irrisolto, gli viene offerta da una giovane fisioterapista – Giorgia in un dignitoso debutto come attrice che non nega comunque la sua straordinaria voce – che, avvertitane la desolata fragilità, lo esorta a tornare in Basilicata per recuperare una foto di gioventù attraverso cui operare un confronto con la contratta postura attuale. La sua bella terra, mostrata in inquadrature di struggente bellezza e ammantata di nostalgia, è amata di incondizionato amore anche quando si rivela impermeabile tanto al male quanto al bene e risultano pertanto corrosive, polemiche ed esilaranti alcune scene, come quella in cui nessuno mostra entusiasmo per la nomina di Matera a Capitale europea della cultura 2019 e quella in cui il becero automobilista che gli offre un passaggio prospetta per Potenza uno sviluppo futuristico in stile Dubai. Lì, a Lauria, si trova il bandolo della matassa e della semplice storia del mite Orlando, avvezzo ad un consumo ormai anestetico di spinelli e disposto ad arrabbiarsi solo su discutibili e anacronistiche questioni di principio, si recupera il passato in ampi flashback. La politica, gli intrallazzi e il terrorismo hanno teso una corda sul suo cammino. Lui non è inciampato, ma lo hanno fatto le persone più care, soprattutto la sorella che non si innamora di un’ideologia, quanto della sua distorsione e del suo malinteso senso di giustizia radicale. E allora la fuga si prospetta come il male minore, la soluzione più comoda, la pietra tombale sulla gioia e sulla poesia che aveva coltivato sin da bambino, persino sul dialetto cui lo sprona invece il giovane se stesso suggerendo così che senza le radici si appassisce soltanto. Si può fare pace con il passato e andare avanti anche a sessant’anni, ma prima bisogna guardare in faccia i fantasmi del passato, restituire loro la voce, sfiorarne la pelle invecchiata, accettare l’assenza del pentimento che non comporta lo spegnersi degli affetti, perdonare. E dietro quei fantasmi o nelle stanze impolverate della vecchia casa si possono trovare altre verità che sgretolano certezze per costruirne di nuove.
Si può fare pace con il passato e andare avanti anche a sessant’anni, ma prima bisogna guardare in faccia i fantasmi del passato, restituire loro la voce, sfiorarne la pelle invecchiata, accettare l’assenza del pentimento che non comporta lo spegnersi degli affetti, perdonare. E dietro quei fantasmi o nelle stanze impolverate della vecchia casa si possono trovare altre verità che sgretolano certezze per costruirne di nuove.




 La vita o si vive o si scrive diceva Pirandello e il nostro Leyland, come alcuni dei suoi compagni di viaggio, sembra indugiare in questa affermazione fino ad aderirvi in modo più o meno consapevole. Da qualunque angolazione la si guardi, la scrittura appare come un atto in sé monumentale, una cerimonia sacra, una terapia dolorosa, un rito per pochi iniziati capaci di dedicarvi le ragioni e il tempo della propria esistenza. “E all’alba spesso mi ritrovavo seduto alla scrivania e pensavo: foss’anche questo l’ultimo giorno, vorrei passarlo con le parole”.
La vita o si vive o si scrive diceva Pirandello e il nostro Leyland, come alcuni dei suoi compagni di viaggio, sembra indugiare in questa affermazione fino ad aderirvi in modo più o meno consapevole. Da qualunque angolazione la si guardi, la scrittura appare come un atto in sé monumentale, una cerimonia sacra, una terapia dolorosa, un rito per pochi iniziati capaci di dedicarvi le ragioni e il tempo della propria esistenza. “E all’alba spesso mi ritrovavo seduto alla scrivania e pensavo: foss’anche questo l’ultimo giorno, vorrei passarlo con le parole”.



 Ecco che il personaggio Boccaccio, nel quale Avati si rispecchia e che pronuncia parole che in realtà gli appartengono, diviene protagonista accanto al suo idolo, si fa riflesso di una visione nuova e sotto certi aspetti romantica che consegna Dante agli spettatori negli anni della giovinezza segnata dal dissidio tra ragione e sentimento.
Ecco che il personaggio Boccaccio, nel quale Avati si rispecchia e che pronuncia parole che in realtà gli appartengono, diviene protagonista accanto al suo idolo, si fa riflesso di una visione nuova e sotto certi aspetti romantica che consegna Dante agli spettatori negli anni della giovinezza segnata dal dissidio tra ragione e sentimento. Di alto livello tutta la recitazione, ma emergono, per la particolare forza espressiva, Romano Reggiani che ben rappresenta la fierezza aristocratica di Guido Cavalcanti, Leopoldo Mastelloni che porge un Bonifacio VIII grottesco, untuoso, viscido e querulo, e poi ancora Alessandro Haber, l’indignato abate di Vallombrosa, Enrico Lo Verso, il fiducioso compagno di viaggio Donato degli Albanzani, Milena Vukotic, la rigattiera, Erica Blanc, Gemma Donati anziana, Morena Gentile, la donna gozzuta, Gianni Cavina, il vecchio Piero Giardina e Valeria D’Obici che regala a Suor Beatrice un’intensità di rara bellezza. A lei e a Sergio Castellitto la scena finale del film – un approdo per Boccaccio, una carezza per l’anziana monaca amareggiata che non riesce a perdonare – che si imprime negli occhi e nel cuore: un uomo e una donna si tengono per mano nella penombra del chiostro, alle loro spalle, non visibile ma evocato, l’Albero del Paradiso che non produce più mele dalla morte del Poeta e tutt’intorno il tenue baluginio di lucciole che sembrano stelle, quelle stelle di cui il Poeta conosceva tutti i nomi, quelle stelle che chiudono le tre cantiche con un’unica parola.
Di alto livello tutta la recitazione, ma emergono, per la particolare forza espressiva, Romano Reggiani che ben rappresenta la fierezza aristocratica di Guido Cavalcanti, Leopoldo Mastelloni che porge un Bonifacio VIII grottesco, untuoso, viscido e querulo, e poi ancora Alessandro Haber, l’indignato abate di Vallombrosa, Enrico Lo Verso, il fiducioso compagno di viaggio Donato degli Albanzani, Milena Vukotic, la rigattiera, Erica Blanc, Gemma Donati anziana, Morena Gentile, la donna gozzuta, Gianni Cavina, il vecchio Piero Giardina e Valeria D’Obici che regala a Suor Beatrice un’intensità di rara bellezza. A lei e a Sergio Castellitto la scena finale del film – un approdo per Boccaccio, una carezza per l’anziana monaca amareggiata che non riesce a perdonare – che si imprime negli occhi e nel cuore: un uomo e una donna si tengono per mano nella penombra del chiostro, alle loro spalle, non visibile ma evocato, l’Albero del Paradiso che non produce più mele dalla morte del Poeta e tutt’intorno il tenue baluginio di lucciole che sembrano stelle, quelle stelle di cui il Poeta conosceva tutti i nomi, quelle stelle che chiudono le tre cantiche con un’unica parola.