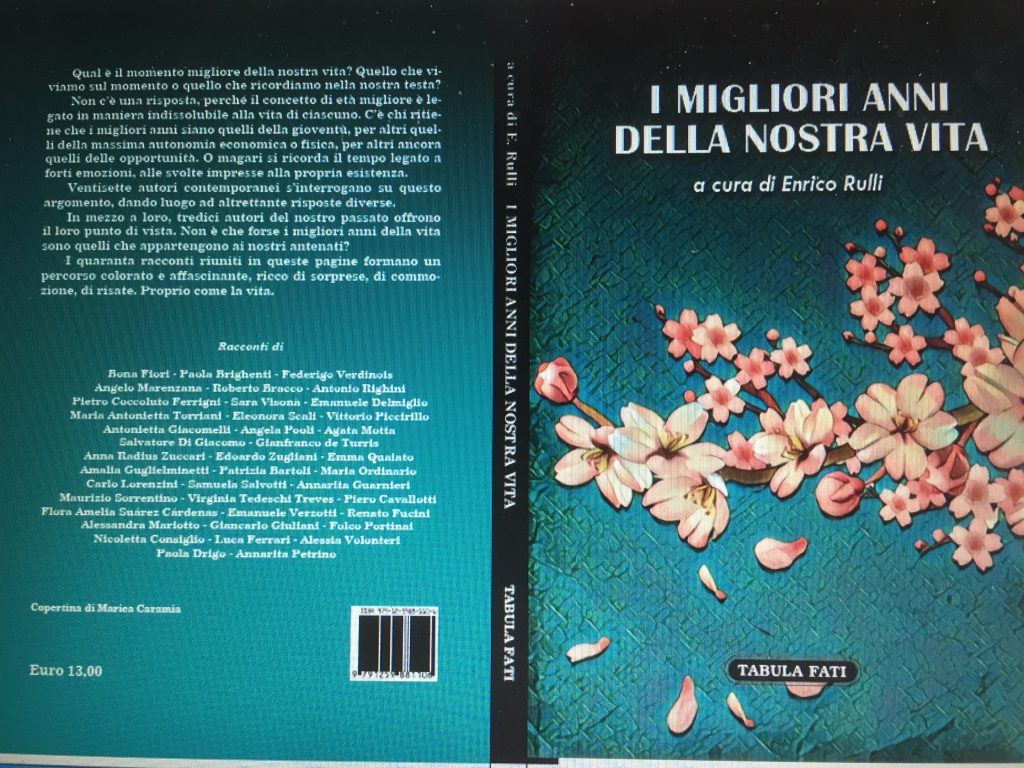“Scordato” di Rocco Papaleo
Cinema, Saggistica breve, Scordato, Rocco Papaleo, Giorgia, Vision Distribution
Vivere in sordina. “Scordato” di Rocco Papaleo
@ Agata Motta, 14 maggio 2023
Un film delizioso Scordato, l’ultimo lavoro di un Rocco Papaleo, disposto a svelarsi in modo più diretto senza rinunciare al proprio stile, anzi prendendone pieno possesso, camminando in bilico tra temi e luoghi frequentati e nuove istanze senza mai ripetersi, disorientare o peggio scivolare.
 Giunto all’ingrato approdo dei sessant’anni con la consapevolezza della propria rassegnazione ad un opaco presente di depressione e di contratture fisiche ed emotive, l’accordatore di pianoforte Orlando – lo stesso Papaleo che firma anche sceneggiatura (con Valter Lupo) e regia – avverte con sempre maggiore insistenza la voce critica (e la presenza fisica) del se stesso giovane (il solare Simone Corbisiero), allegro e pieno di speranze, e di un passato, chiuso ormai fuori a doppia mandata, che vorrebbe confusamente risucchiarlo. Il motivo si scoprirà poco alla volta, perché in quel passato è da collocare il trauma che ha portato il giovane Orlando alla fuga da Lauria, il paese lucano di origine, nonostante il forte legame che lo univa alla bellissima madre (Manola Rotunno), della quale malvolentieri aveva accettato le seconde nozze con l’albergatore Rocchino (Jerry Potenza) e all’esuberante sorella Rosanna (valida e calzante Angela Curri). La possibilità di riavvolgere il nastro e di sciogliere l’amaro garbuglio che ne ha fatto un eterno irrisolto, gli viene offerta da una giovane fisioterapista – Giorgia in un dignitoso debutto come attrice che non nega comunque la sua straordinaria voce – che, avvertitane la desolata fragilità, lo esorta a tornare in Basilicata per recuperare una foto di gioventù attraverso cui operare un confronto con la contratta postura attuale. La sua bella terra, mostrata in inquadrature di struggente bellezza e ammantata di nostalgia, è amata di incondizionato amore anche quando si rivela impermeabile tanto al male quanto al bene e risultano pertanto corrosive, polemiche ed esilaranti alcune scene, come quella in cui nessuno mostra entusiasmo per la nomina di Matera a Capitale europea della cultura 2019 e quella in cui il becero automobilista che gli offre un passaggio prospetta per Potenza uno sviluppo futuristico in stile Dubai. Lì, a Lauria, si trova il bandolo della matassa e della semplice storia del mite Orlando, avvezzo ad un consumo ormai anestetico di spinelli e disposto ad arrabbiarsi solo su discutibili e anacronistiche questioni di principio, si recupera il passato in ampi flashback. La politica, gli intrallazzi e il terrorismo hanno teso una corda sul suo cammino. Lui non è inciampato, ma lo hanno fatto le persone più care, soprattutto la sorella che non si innamora di un’ideologia, quanto della sua distorsione e del suo malinteso senso di giustizia radicale. E allora la fuga si prospetta come il male minore, la soluzione più comoda, la pietra tombale sulla gioia e sulla poesia che aveva coltivato sin da bambino, persino sul dialetto cui lo sprona invece il giovane se stesso suggerendo così che senza le radici si appassisce soltanto.
Giunto all’ingrato approdo dei sessant’anni con la consapevolezza della propria rassegnazione ad un opaco presente di depressione e di contratture fisiche ed emotive, l’accordatore di pianoforte Orlando – lo stesso Papaleo che firma anche sceneggiatura (con Valter Lupo) e regia – avverte con sempre maggiore insistenza la voce critica (e la presenza fisica) del se stesso giovane (il solare Simone Corbisiero), allegro e pieno di speranze, e di un passato, chiuso ormai fuori a doppia mandata, che vorrebbe confusamente risucchiarlo. Il motivo si scoprirà poco alla volta, perché in quel passato è da collocare il trauma che ha portato il giovane Orlando alla fuga da Lauria, il paese lucano di origine, nonostante il forte legame che lo univa alla bellissima madre (Manola Rotunno), della quale malvolentieri aveva accettato le seconde nozze con l’albergatore Rocchino (Jerry Potenza) e all’esuberante sorella Rosanna (valida e calzante Angela Curri). La possibilità di riavvolgere il nastro e di sciogliere l’amaro garbuglio che ne ha fatto un eterno irrisolto, gli viene offerta da una giovane fisioterapista – Giorgia in un dignitoso debutto come attrice che non nega comunque la sua straordinaria voce – che, avvertitane la desolata fragilità, lo esorta a tornare in Basilicata per recuperare una foto di gioventù attraverso cui operare un confronto con la contratta postura attuale. La sua bella terra, mostrata in inquadrature di struggente bellezza e ammantata di nostalgia, è amata di incondizionato amore anche quando si rivela impermeabile tanto al male quanto al bene e risultano pertanto corrosive, polemiche ed esilaranti alcune scene, come quella in cui nessuno mostra entusiasmo per la nomina di Matera a Capitale europea della cultura 2019 e quella in cui il becero automobilista che gli offre un passaggio prospetta per Potenza uno sviluppo futuristico in stile Dubai. Lì, a Lauria, si trova il bandolo della matassa e della semplice storia del mite Orlando, avvezzo ad un consumo ormai anestetico di spinelli e disposto ad arrabbiarsi solo su discutibili e anacronistiche questioni di principio, si recupera il passato in ampi flashback. La politica, gli intrallazzi e il terrorismo hanno teso una corda sul suo cammino. Lui non è inciampato, ma lo hanno fatto le persone più care, soprattutto la sorella che non si innamora di un’ideologia, quanto della sua distorsione e del suo malinteso senso di giustizia radicale. E allora la fuga si prospetta come il male minore, la soluzione più comoda, la pietra tombale sulla gioia e sulla poesia che aveva coltivato sin da bambino, persino sul dialetto cui lo sprona invece il giovane se stesso suggerendo così che senza le radici si appassisce soltanto.
 Si può fare pace con il passato e andare avanti anche a sessant’anni, ma prima bisogna guardare in faccia i fantasmi del passato, restituire loro la voce, sfiorarne la pelle invecchiata, accettare l’assenza del pentimento che non comporta lo spegnersi degli affetti, perdonare. E dietro quei fantasmi o nelle stanze impolverate della vecchia casa si possono trovare altre verità che sgretolano certezze per costruirne di nuove.
Si può fare pace con il passato e andare avanti anche a sessant’anni, ma prima bisogna guardare in faccia i fantasmi del passato, restituire loro la voce, sfiorarne la pelle invecchiata, accettare l’assenza del pentimento che non comporta lo spegnersi degli affetti, perdonare. E dietro quei fantasmi o nelle stanze impolverate della vecchia casa si possono trovare altre verità che sgretolano certezze per costruirne di nuove.
Se la prima scena, in cui Orlando quasi si immola ad un incontro sessuale che non giungerà a compimento per una contrattura alla schiena – l’occasione narrativa che darà seguito al resto della storia – sembra condurre ai noti sentieri umoristici dell’autore, bastano poco per realizzare che questo è un film in parte diverso, intriso di malinconia e tenerezza, e tutto ciò che di noto torna del Papaleo precedente viene restituito filtrato da una nuova coscienza di sé, da un’indagine interiore di nuovo e più robusto spessore che travolge e a tratti persino commuove. Lo sguardo di Papaleo, anche attraverso il confronto con quello scanzonato e provocatorio di Corbisiero, assume una drammatica intensità e se le labbra pronunciano parole che strappano il sorriso, gli occhi raccontano un dolore reale, quello di esseri umani che vivono in sordina, che accordano strumenti altrui glissando sulle proprie dissonanze, sui sogni calpestati da una vita che ha imboccato direzioni impreviste e non scelte.
 Verrebbe quasi voglia di abbracciarlo stretto stretto quando, incoraggiato e illuso dagli amichevoli atteggiamenti della fisioterapista, si ritrova respinto e solo a realizzare la propria inesorabile vecchiaia e ancora abbracci a profusione quando, riappropriatosi della vena poetica giovanile per puro uso personale (meglio scrivere che strafarsi di spinelli) avanza sul pontile scandendo bellissimi versi (parte del testo di Tu sei una parte di me, la canzone che accompagna i titoli di coda cantata da Giorgia e Papaleo) e lasciandosi alle spalle le persone del passato e del presente senza rinnegarle, semplicemente oltrepassandole per godere di un attimo di compiutezza.
Verrebbe quasi voglia di abbracciarlo stretto stretto quando, incoraggiato e illuso dagli amichevoli atteggiamenti della fisioterapista, si ritrova respinto e solo a realizzare la propria inesorabile vecchiaia e ancora abbracci a profusione quando, riappropriatosi della vena poetica giovanile per puro uso personale (meglio scrivere che strafarsi di spinelli) avanza sul pontile scandendo bellissimi versi (parte del testo di Tu sei una parte di me, la canzone che accompagna i titoli di coda cantata da Giorgia e Papaleo) e lasciandosi alle spalle le persone del passato e del presente senza rinnegarle, semplicemente oltrepassandole per godere di un attimo di compiutezza.
Ci vorrebbe un ago e non un’agonia per imparare la pazienza del sarto che cuce vestiti e feriti
Spero ci venga in mente un pensiero esilarante, quelli che fanno ridere di questa inconsistenza
E per un attimo, ingannevolmente, ci rendono compiuti (Tu sei una parte di me).
https://www.scriptandbooks.it/2023/05/14/vivere-in-sordina-scordato-di-rocco-papaleo/
anche su Articolo21
https://www.articolo21.org/2023/05/vivere-in-sordina-scordato-di-rocco-papaleo/




 La vita o si vive o si scrive diceva Pirandello e il nostro Leyland, come alcuni dei suoi compagni di viaggio, sembra indugiare in questa affermazione fino ad aderirvi in modo più o meno consapevole. Da qualunque angolazione la si guardi, la scrittura appare come un atto in sé monumentale, una cerimonia sacra, una terapia dolorosa, un rito per pochi iniziati capaci di dedicarvi le ragioni e il tempo della propria esistenza. “E all’alba spesso mi ritrovavo seduto alla scrivania e pensavo: foss’anche questo l’ultimo giorno, vorrei passarlo con le parole”.
La vita o si vive o si scrive diceva Pirandello e il nostro Leyland, come alcuni dei suoi compagni di viaggio, sembra indugiare in questa affermazione fino ad aderirvi in modo più o meno consapevole. Da qualunque angolazione la si guardi, la scrittura appare come un atto in sé monumentale, una cerimonia sacra, una terapia dolorosa, un rito per pochi iniziati capaci di dedicarvi le ragioni e il tempo della propria esistenza. “E all’alba spesso mi ritrovavo seduto alla scrivania e pensavo: foss’anche questo l’ultimo giorno, vorrei passarlo con le parole”.



 Ecco che il personaggio Boccaccio, nel quale Avati si rispecchia e che pronuncia parole che in realtà gli appartengono, diviene protagonista accanto al suo idolo, si fa riflesso di una visione nuova e sotto certi aspetti romantica che consegna Dante agli spettatori negli anni della giovinezza segnata dal dissidio tra ragione e sentimento.
Ecco che il personaggio Boccaccio, nel quale Avati si rispecchia e che pronuncia parole che in realtà gli appartengono, diviene protagonista accanto al suo idolo, si fa riflesso di una visione nuova e sotto certi aspetti romantica che consegna Dante agli spettatori negli anni della giovinezza segnata dal dissidio tra ragione e sentimento. Di alto livello tutta la recitazione, ma emergono, per la particolare forza espressiva, Romano Reggiani che ben rappresenta la fierezza aristocratica di Guido Cavalcanti, Leopoldo Mastelloni che porge un Bonifacio VIII grottesco, untuoso, viscido e querulo, e poi ancora Alessandro Haber, l’indignato abate di Vallombrosa, Enrico Lo Verso, il fiducioso compagno di viaggio Donato degli Albanzani, Milena Vukotic, la rigattiera, Erica Blanc, Gemma Donati anziana, Morena Gentile, la donna gozzuta, Gianni Cavina, il vecchio Piero Giardina e Valeria D’Obici che regala a Suor Beatrice un’intensità di rara bellezza. A lei e a Sergio Castellitto la scena finale del film – un approdo per Boccaccio, una carezza per l’anziana monaca amareggiata che non riesce a perdonare – che si imprime negli occhi e nel cuore: un uomo e una donna si tengono per mano nella penombra del chiostro, alle loro spalle, non visibile ma evocato, l’Albero del Paradiso che non produce più mele dalla morte del Poeta e tutt’intorno il tenue baluginio di lucciole che sembrano stelle, quelle stelle di cui il Poeta conosceva tutti i nomi, quelle stelle che chiudono le tre cantiche con un’unica parola.
Di alto livello tutta la recitazione, ma emergono, per la particolare forza espressiva, Romano Reggiani che ben rappresenta la fierezza aristocratica di Guido Cavalcanti, Leopoldo Mastelloni che porge un Bonifacio VIII grottesco, untuoso, viscido e querulo, e poi ancora Alessandro Haber, l’indignato abate di Vallombrosa, Enrico Lo Verso, il fiducioso compagno di viaggio Donato degli Albanzani, Milena Vukotic, la rigattiera, Erica Blanc, Gemma Donati anziana, Morena Gentile, la donna gozzuta, Gianni Cavina, il vecchio Piero Giardina e Valeria D’Obici che regala a Suor Beatrice un’intensità di rara bellezza. A lei e a Sergio Castellitto la scena finale del film – un approdo per Boccaccio, una carezza per l’anziana monaca amareggiata che non riesce a perdonare – che si imprime negli occhi e nel cuore: un uomo e una donna si tengono per mano nella penombra del chiostro, alle loro spalle, non visibile ma evocato, l’Albero del Paradiso che non produce più mele dalla morte del Poeta e tutt’intorno il tenue baluginio di lucciole che sembrano stelle, quelle stelle di cui il Poeta conosceva tutti i nomi, quelle stelle che chiudono le tre cantiche con un’unica parola.
 Franca e Rosa sono due tabacchine, lavorano e contribuiscono al mantenimento delle loro famiglie. Questo le colloca già su un piano diverso rispetto alle loro madri, sono quasi privilegiate nonostante le mortificazioni e le vessazioni che sono costrette ad ingoiare dai loro capi, uomini, ovviamente, perché soltanto agli uomini (siano essi datori di lavoro, mariti o padri) è permesso comandare e manovrare la vita delle donne. Sono diverse sia fisicamente che come temperamento, e pertanto complementari, ma sanno di possedere il dono prezioso della complicità e della reciproca comprensione.
Franca e Rosa sono due tabacchine, lavorano e contribuiscono al mantenimento delle loro famiglie. Questo le colloca già su un piano diverso rispetto alle loro madri, sono quasi privilegiate nonostante le mortificazioni e le vessazioni che sono costrette ad ingoiare dai loro capi, uomini, ovviamente, perché soltanto agli uomini (siano essi datori di lavoro, mariti o padri) è permesso comandare e manovrare la vita delle donne. Sono diverse sia fisicamente che come temperamento, e pertanto complementari, ma sanno di possedere il dono prezioso della complicità e della reciproca comprensione.

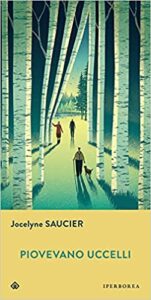 Sebbene la narrazione e il punto di vista siano prevalentemente quelli di Severino, l’autore lascia ampi spazi ad Anna, affidandoli ad un narratore onnisciente che ne racconta il passato e la vita sbagliata in cui si è infilata con le proprie mani, e qualche capitolo a Peppe (forse con una lieve forzatura, non tanto sul piano delle intenzioni quanto su quello del risultato complessivo) di cui pian piano affiora il vissuto, dal punto in cui ha abbandonato la famiglia, e infine il rimorso che lo condurrà ad un gesto indirettamente risarcitorio. L’amore per la libertà, che Peppe ha inculcato alla figlia che ha avvertito a lui più simile e vicina, qui coincide con la fuga.
Sebbene la narrazione e il punto di vista siano prevalentemente quelli di Severino, l’autore lascia ampi spazi ad Anna, affidandoli ad un narratore onnisciente che ne racconta il passato e la vita sbagliata in cui si è infilata con le proprie mani, e qualche capitolo a Peppe (forse con una lieve forzatura, non tanto sul piano delle intenzioni quanto su quello del risultato complessivo) di cui pian piano affiora il vissuto, dal punto in cui ha abbandonato la famiglia, e infine il rimorso che lo condurrà ad un gesto indirettamente risarcitorio. L’amore per la libertà, che Peppe ha inculcato alla figlia che ha avvertito a lui più simile e vicina, qui coincide con la fuga.
 Il dilemma parte da un vecchio film di Fritz Lang, girato nel 1941 quando ancora gli Stati Uniti non erano entrati nel conflitto. In esso un oscuro cacciatore interpretato da George Sanders si accosta con un fucile di precisione al luogo più sorvegliato della Germania, la villa a Berchtesgaden in cui Hitler si ritirava spesso. L’uomo lo inquadra nel mirino, spara consapevolmente un colpo a vuoto, poi lo inquadra di nuovo e potrebbe stavolta con il suo sparo raggiungere il suo obiettivo. Ma tutto questo non avviene e la Storia prende la strada della catastrofe. Stessa cosa, ma stavolta scendiamo sul piano della realtà, capita allo scrittore Friedrich Reck-Malleczewen che, nel suo Diario di un disperato, racconta come, pur avendo avuto l’occasione e la tentazione di eliminare Hitler con facilità, non lo aveva fatto, sostanzialmente perché lo aveva percepito come “un personaggio da vignetta comica”. Certo non poteva ancora sapere che lui stesso sarebbe morto in un campo di concentramento. Se gli sviluppi futuri fossero stati chiari e lampanti con congruo anticipo, anche uccidere avrebbe avuto un altro peso, un’altra morale, un altro provvidenziale spessore. È l’irreversibilità della morte a creare profonde lacerazioni interiori, l’impossibilità di tornare indietro, di rimettere tutto a posto, di cancellare persino le tracce di ciò che è avvenuto con un momentaneo atto di volontà.
Il dilemma parte da un vecchio film di Fritz Lang, girato nel 1941 quando ancora gli Stati Uniti non erano entrati nel conflitto. In esso un oscuro cacciatore interpretato da George Sanders si accosta con un fucile di precisione al luogo più sorvegliato della Germania, la villa a Berchtesgaden in cui Hitler si ritirava spesso. L’uomo lo inquadra nel mirino, spara consapevolmente un colpo a vuoto, poi lo inquadra di nuovo e potrebbe stavolta con il suo sparo raggiungere il suo obiettivo. Ma tutto questo non avviene e la Storia prende la strada della catastrofe. Stessa cosa, ma stavolta scendiamo sul piano della realtà, capita allo scrittore Friedrich Reck-Malleczewen che, nel suo Diario di un disperato, racconta come, pur avendo avuto l’occasione e la tentazione di eliminare Hitler con facilità, non lo aveva fatto, sostanzialmente perché lo aveva percepito come “un personaggio da vignetta comica”. Certo non poteva ancora sapere che lui stesso sarebbe morto in un campo di concentramento. Se gli sviluppi futuri fossero stati chiari e lampanti con congruo anticipo, anche uccidere avrebbe avuto un altro peso, un’altra morale, un altro provvidenziale spessore. È l’irreversibilità della morte a creare profonde lacerazioni interiori, l’impossibilità di tornare indietro, di rimettere tutto a posto, di cancellare persino le tracce di ciò che è avvenuto con un momentaneo atto di volontà.