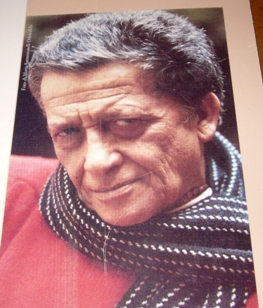Teatro, Saggistica breve, Letteratura
Il destino illeggibile di Gesualdo Bufalino. Intervista a Giulia Randazzo, regista di ‘A noi due’, in scena al Teatro Biondo di Palermo
@ Agata Motta (08-06-2021)

Giulia Randazzo
Strano ma vero: si riparte. Poche parole che si avrebbe voglia di sussurrare per timore che possano svanire, poche parole che si vorrebbero gridare per un’incontenibile gioia che si spera non fugace.
Gran debutto in prima nazionale allo Steri Chiaramonte di Palermo per la nuova produzione del Teatro Biondo: A noi due, ovvero Le menzogne della notte di Gesualdo Bufalino nella messa in scena scritta e diretta da Giulia Randazzo. Lo spettacolo, in scena fino al 13 giugno alle 20.30 (ma con ingresso consigliato alle 20.00 per consentire la visita alle celle dell’ex carcere) è interpretato da Vincenzo Pirrotta, Paolo Briguglia, Mauro Lamantia, Giuseppe Lino, Alessandro Romano.
“In un’isola penitenziaria, probabilmente mediterranea e borbonica, fra equivoche confessioni e angosce d’identità, un gruppo di condannati a morte trascorre l’ultima notte”. Questa la sinossi del romanzo raccontata dallo stesso autore, poco più di un centinaio di pagine di sublime letteratura. “Fantasia storica, giallo metafisico, moralità leggendaria”, con queste parole l’autore definisce un’opera che non è possibile incasellare in un genere specifico, ma che resta incollata nella mente e nel cuore del lettore.
Sebbene del romanzo storico indossi le sontuose vesti e del Decameron adotti l’espediente della cornice narrativa, Le menzogne della notte è un romanzo originalissimo e di magnetico fascino. Il tempo e il luogo, suggeriti ma non palesemente dichiarati, fungono da supporto per raccontare storie di uomini di tempi andati attraversati dagli eterni dubbi esistenziali che appartengono ad ogni epoca, per narrare di violenze subìte o compiute, di lacerazioni interiori, di amori travolgenti, di passioni mortifere, di gelosie, di malesseri, di vendette. Un romanzo totalizzante, che si snoda tutto in interni, con l’unica eccezione di squarci di cielo intravisti dalla finestra e di uno spicchio beffardo di piazza su cui cresce pian piano Luigina, la ghigliottina eretta nel corso della notte che mozzerà il capo a cospiratori irretiti dall’offerta terribile del Governatore: trascorrere l’ultima notte nell’agio del confortatorio con la possibilità di scrivere, nel rispetto dell’anonimato, il nome che svelerà l’identità del “Padreterno”, il capo supremo della cospirazione, e avere in tal modo la salvezza. Tradire vigliaccamente, e ottenere la scarcerazione di tutti, o morire quando ancora la vita seduce e attrae.
“A noi due”, il titolo scelto per lo spettacolo, è l’ambigua, provocatoria dedica che Gesualdo Bufalino scelse per il suo terzo romanzo, vincitore del Premio Strega 1988, una dedica che è anche uno dei tantissimi prestiti letterari (battuta finale del Père Goriot di Balzac in questo caso) con cui l’autore impreziosì un testo densissimo di riflessioni morali e di scavi introspettivi. Dovrebbe essere logico parlare anche di risvolti politici, considerato il contesto, ma in realtà la politica nel romanzo è solo un pretesto, una ragione di vita per i condannati che vi si sono aggrappati alla ricerca di solide certezze; in realtà non si gioca una partita ideologica ma si indaga su una condizione esistenziale.

A noi due suona quindi come una sfida per questo spettacolo di apertura di Eroica, la stagione estiva del Biondo annunciata con giusto entusiasmo dalla direttrice Pamela Villoresi, una sfida al tempo guasto che si è costretti ad affrontare, una sfida alle pressanti difficoltà che bisogna superare, una sfida all’umore aspro che non dovrà alterare i prossimi assaggi di libertà. Allora a noi due: attori e spettatori, teatro e mondo, musica e parole, vita e morte.
La giovane pluripremiata regista palermitana, che ha già a suo attivo una decina di spettacoli complessi e originali, è stata selezionata per la terza edizione di Fabbrica YAP e ha diretto ‘Farnese Suite’, il lungometraggio dei giovani artisti del ‘Fabbrica Young Artist Program’ del Teatro dell’Opera di Roma, in collaborazione con l’Ambasciata di Francia in Italia e l’Opera di Parigi. A lei dunque il gradevole e non semplice compito di orientarci in uno spettacolo accattivante ricco di sollecitazioni e sorprese.
- Chi è per lei Gesualdo Bufalino e cosa vuole raccontarci di lui attraverso lo spettacolo?
Bufalino rappresenta un pezzo della mia tarda adolescenza, come qualcuno la definisce oggi; ossia quel periodo meraviglioso della vita che si colloca tra i 18 e i 20 anni. È il periodo in cui ciascuno di noi è animato dai grandi dubbi esistenziali: chi sono? Chi siamo? Siamo veri? Siamo dipinti? Sono gli stessi dubbi di cui lo scrittore di Comiso ci narra attraverso i personaggi delle sue Menzogne.
Non so se ho voluto raccontare qualcosa in particolare di Bufalino, forse ho solo desiderato che lo spettatore di “A noi due” facesse esperienza di questo autore. Fare esperienza teatrale di Gesualdo Bufalino penso possa rappresentare per l’uomo di oggi una possibilità concreta di sfamare il proprio bisogno metafisico.
- A noi due è definita un’esperienza teatrale “di confine”: quali sono i confini da esplorare o eventualmente da oltrepassare?
Con la pandemia siamo stati letteralmente confinati, separati, ridotti a percepire il mondo attraverso i nostri device, telefoni, computer, Ipad… forse oggi oltrepassare il confine significa ritornare insieme, a condividere una storia nel nostro caso. Ma dobbiamo farlo in sicurezza. Come conciliare la necessità del distanziamento con il bisogno di comunità? Come conciliare l’intimità di un romanzo ambientato in un interno notte con norme che incoraggiano a svolgere spettacoli in grandi spazi esterni?
Dalla necessità di cercare una risposta a queste domande e di superare i confini che connotano dolorosamente il periodo storico in cui viviamo è nata la sperimentazione che – insieme alla scenografa Giulia Bellé e al sound artist Alessandro Librio – ho proposto al Teatro e alla compagnia: mettere il pubblico nelle condizioni di essere vicino alla parola bufaliniana e agli attori che l’hanno incarnata con altri sensi, in questo caso privilegiando quello dell’udito. Ne è nato un rapporto fra spettatore e attore abbastanza inedito, diverso, anche più intimo in un certo senso…
Ho serie difficoltà a definire “A noi due” uno spettacolo: è stata al tempo stesso una sfida e una “affettuosa intimidazione” (come direbbe Bufalino) che, come compagnia, abbiamo rivolto allo spettatore, chiamato a mettersi in gioco in un rapporto uno-a-uno con il palcoscenico, alla ricerca di nuove forme di intimità nella distanza.
- Il romanzo di Bufalino ha un impianto pienamente teatrale e apparentemente statico, quasi claustrofobico visto che si svolge perlopiù nello spazio chiuso del confortatorio, ma lei ha voluto contrapporvi un andamento più dinamico, legato al luogo della rappresentazione. Quanto ha influito la scelta dello Steri sulla modalità dell’allestimento?
“Apparentemente statico”, hai detto bene, perché in realtà con il passare delle ore i personaggi subiscono una trasformazione incredibile, molto evidente, palpabile, emozionante. Ho puntato sin dall’inizio sulla possibilità che gli attori si facessero portatori della parte più “spettacolare” di questa storia. Ho lavorato insieme a loro per costruire un percorso che potesse trasformare questo linguaggio così desueto e a tratti insidioso, in un viaggio appassionante e coinvolgente. Il “confortatorio” poi, nelle intenzioni dello stesso Bufalino, diventa il palcoscenico del mondo. È una metafora shakespeariana, è nell’essenza del fare teatro e nel testo questo tema ricorre nelle parole di tutti i personaggi: realtà e finzione, essere e apparire, essere degli individui consapevoli o delle marionette nelle mani di un destino illeggibile?
Ho pensato che lo Steri Chiaramonte fosse il luogo ideale per raccontare questa storia, per il suo passato e per le memorie che ancora lo abitano, a partire dai dipinti che i prigionieri hanno lasciato sui muri delle celle. Abitare per l’ultima settimana di prove lo Steri, trovarsi mani e piedi immersi in quelle memorie, più che influenzare a livello prassico le modalità di allestimento, ha segnato nel profondo tutti noi.
- Tra i personaggi del romanzo quale ha sentito più vicino o più interessante durante la stesura dell’adattamento teatrale?
Ad essere sincera non saprei scegliere un personaggio fra gli altri… e forse questa è la forza di questa drammaturgia. Ognuno di loro è un frammento di un tutto. Ognuno di loro ci parla di qualcosa, di un segreto che gli altri non conoscono. Durante questa “notte di meraviglie” non si rivelano soltanto agli spettatori, ma l’uno con l’altro, generando ad ogni loro racconto una nuova possibilità di senso, di significato per il gesto che stanno per compiere, per il loro sacrificio. È una grandissima soddisfazione vedere come il pubblico si affezioni ad ognuno dei personaggi e apprezzi il cast nella sua interezza e diversità. Ad un certo punto si ha l’impressione di essere nella cella con loro.
- La pirandelliana ricerca della propria identità è uno dei motivi conduttori dei racconti dei personaggi, sembra quasi che scelgano di smarrirsi nel tentativo di ritrovarsi. In realtà nessuno aderisce in pieno alla propria rappresentazione di sé, la menzogna è sempre dietro l’angolo. E’ il destino dell’essere umano?
Temo di sì. Per paradosso in questa storia la menzogna sembra svelarci, come in un racconto mitico, una verità sull’uomo più autentica di quanto non possa farlo la banalità di una confessione sincera. Come se Bufalino si diverta a confonderci, e a confondersi, per poi riemergere dal caos con un piccolo diamante sulla punta della sua penna. La fragilità umana, la consapevolezza di questa fragilità, e la poesia che ne derivano sono incredibilmente toccanti.
- “Decisioni sull’uso della notte” è il titolo di uno dei capitoli del romanzo. La notte in questione però è, con quasi assoluta certezza, l’ultima e i personaggi la trascorreranno raccontandosi brandelli di vita. Quanta e quale salvezza si può trovare nelle parole?
Per risponderti, mi viene voglia di citarti per intero una parte della drammaturgia, l’unica che mi sono permessa di interpolare, perché trovavo le interviste di Bufalino sul tema del rapporto fra morte, abisso e racconto, così belle che mi sono sentita in dovere di condividerle col pubblico. Ma non lo farò! Sta agli spettatori più attenti andarle a scovare…
- Con quanta fedeltà ha affrontato il linguaggio barocco e lussureggiante dell’autore?
Totale, devota, quasi assoluta, mi sono permessa di spostare piccole cose affinché non fosse sacrificata – per i tagli al testo che necessariamente andavano fatti – la comprensione della storia. Anzi durante le prove abbiamo recuperato alcune espressioni che avevo in un primo momento obliato perché temevo impossibili da recitare!
Questo perché abbiamo tutti accettato la sfida di questo linguaggio, così difficile in apparenza, eppure così ricco di senso, generatore di suoni, di poesia, capace di aprire all’improvviso uno squarcio nella tela della finzione.
Il lavoro più duro e appassionante sul linguaggio non è stato dunque nella stesura dell’adattamento, ma nella costante ricerca di una verità nella recitazione di quelle parole. Sono molto grata a ciascuno dei membri del cast, che si è misurato insieme a me in questa impresa coraggiosa e folle.
- Vincenzo Pirrotta, Paolo Briguglia, Mauro Lamantia, Giuseppe Lino, Alessandro Romano sono attori molto diversi tra loro per presenza scenica, gestualità, inflessioni vocali. L’attribuzione dei ruoli è stata naturale e spontanea?
Sì, naturale e spontanea; non avrei saputo dirlo meglio. Ciò che invece non è stato spontaneo né semplice è stato il processo di direzione attori in una compagnia così eterogenea per percorsi professionali e di vita. Un viaggio ricco e stimolante, anche in questo caso una bella sfida: credo che un regista non possa desiderare di più. Paolo, Vincenzo, Mauro, Giuseppe e Alessandro sono stati 5 meravigliosi compagni di viaggio, ciascuno di loro mi ha aperto con generosità e fiducia una finestra sul proprio mondo. Nel mio piccolo, ho provato a fare lo stesso. Sono estremamente grata alla vita per questa opportunità umana, prima ancora che professionale.
In un’epoca storica in cui il teatro è schiavo di decreti ministeriali ghettizzano under e over 35, nuove drammaturgie e teatro classico, credo sia tornato il momento di ricominciare a prendere sul serio il teatro come fatto intergenerazionale, fatto di incontri, scontri, passaggi di testimone.
- Il suono, che potrebbe sembrare quasi un intruso nel silenzio tetro del penitenziario in cui si trovano i quattro condannati, diventa protagonista nello spettacolo. Che funzione ha voluto attribuirgli?
Nel romanzo il suono ha un ruolo fondamentale. I detenuti raccontano le loro storie nella penombra. Bufalino spende moltissime parole per descrivere i timbri vocali dei vari personaggi, per raccontare suoni e rumori che caratterizzano l’isola. Alcuni di questi, segnano per i detenuti l’unico modo per percepire lo scorrere del tempo durante la notte nel confortatorio (l’avvicendarsi delle ronde dei soldati, il rumore dei martelli che inchiodano il patibolo, la lama della ghigliottina la cui efficacia viene testata sul capo di alcuni malcapitati animali).
Insieme ad Alessandro Librio abbiamo immaginato lo Steri Chiaramonte come il corrispettivo di un grande labirinto mentale in cui il tempo presente si confonde e si sovrappone a quello del ricordo. Gli ambienti sonori che ha realizzato Alessandro sono paesaggi della memoria in cui si combinano elementi legati tanto al passato dell’autore, quanto a quello dei personaggi del suo romanzo. Dal punto di vista del suono abbiamo cercato di rendere percepibile a livello uditivo l’ambiguità della verità e la sua relatività – centrale nel testo di Bufalino – lavorando sull’integrazione tra suoni distorti e suoni realistici, registrati in presa diretta.
È stato molto divertente assistere allo spettacolo e vedere come il pubblico a un certo punto abbia avuto difficoltà a capire quali suoni fossero veri e quali no, specie per quello che concerne i suoni naturali… la messa in dubbio della verità sonora, insomma!
- Torniamo alla prima domanda ma con una piccola modifica: cosa vuole raccontarci di se stessa Giulia Randazzo attraverso il suo spettacolo?
Come ho accennato, sono legata allo scrittore di Comiso da ragioni personali e affettive. L’incontro con questo autore ha coinciso per me con l’incontro con un professore che ha segnato profondamente la mia vita personale e artistica e che amo definire “il mio maestro”, nonostante non sia un teatrante. Mi diceva sempre: “Giulietta, se vuoi imparare davvero a scrivere devi leggere Gesualdo Bufalino!”. E così feci… per obbedienza, per affetto. Chissà. A dire il vero, non ho mai imparato a scrivere, ma conservo un ricordo meraviglioso di quelle letture e di quegli anni. Le Menzogne della Notte era il suo romanzo bufaliniano d’elezione e me lo fece amare profondamente.
Forse con questo titolo ho voluto raccontare qualcosa del nostro rapporto, del nostro amore per la ricerca sincera e appassionata della verità.
Le nostre strade si sono separate poco dopo: lui oggi continua a ricercarla nella sua attività accademica; io mi ostino a farlo sulle tavole del palcoscenico, tra la polvere e i testi, insieme a delle creature meravigliose chiamate “attori”.
Credo che il mio prof. non sia mai stato troppo felice di questo… forse avrebbe preferito vedermi in cattedra.
Invece il prof. sicuramente saprà apprezzare la scelta, perché non c’è niente di più bello e prezioso che porgere le ali ai propri alunni e aiutarli a riconoscere la propria strada.
Nelle menzogne di questa anomala notte bufaliniana, si porgono alla coscienza dello spettatore le domande di sempre con la stessa intensità di sempre: sulla vita e sull’uso che ciascuno di noi ne ha fatto quando ormai non si ha più la possibilità di modificare nulla, e sul tempo, nella sua specialissima caratteristica di farsi breve o eterno a seconda delle situazioni e delle percezioni soggettive. Non si finirà mai di tessere meravigliosi orditi sui grandi misteri che l’uomo è tenuto, suo malgrado, a guardare dritto negli occhi.
A noi due
ovvero Le menzogne della notte di Gesualdo Bufalino
drammaturgia e regia Giulia Randazzo
scene e costumi Giulia Bellé
musiche originali e sound design Alessandro Librio
con Vincenzo Pirrotta, Paolo Briguglia
e con Mauro Lamantia, Giuseppe Lino, Alessandro Romano
luci Antonio Sposito
fonica Danilo Pasca
direttore di scena Sergio Beghi
https://www.scriptandbooks.it/2021/06/21/il-destino-illeggibile-di-gesualdo-bufalino-intervista-a-giulia-randazzo-regista-di-a-noi-due-in-scena-al-teatro-biondo-di-palermo/
anche su Articolo21
https://www.articolo21.org/2021/06/il-destino-illeggibile-di-gesualdo-bufalino-intervista-a-giulia-randazzo-regista-di-a-noi-due-in-scena-al-teatro-biondo-di-palermo/




 Foto © ANSA/Ansa
Foto © ANSA/Ansa